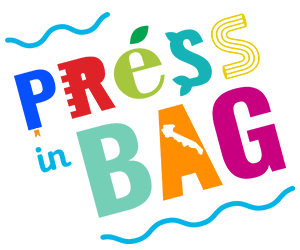
www.pressinbag.it è una testata giornalistica iscritta al n. 10/2021 del Registro della Stampa del Tribunale di Bari del 10/05/2021.

Arriva, cerca un attimo di tregua dalla corsa contro il tempo.
Si prende pochi attimi prima di iniziare e poi come un fiume in piena parla di libri, scrittori, scrittrici, editori, lettori. Parla di tutto ciò che ruota intorno ad un libro tessendo una trama che inevitabilmente porta ad una conclusione: il discorso sui libri è e deve essere un discorso collettivo, mai individuale. I nodi che connettono tutto ciò che orbita intorno ai libri sono per definizione intrecciati, slegandoli la trama viene via e con essa anche i libri. Loredana Lipperini, scrittrice, autrice radiofonica, conduttrice e mille altre cose sale sul palco del fortino Sant’Antonio di Bari e inizia a parlare di libri con grazia, ironia, preoccupazione sì, ma anche speranza.
Parte dal passato, dall’esperimento che Tommaso Spazzini Villa ha fatto con il suo Autoritratti edito da Quodlibet, dove l’Odissea di Omero tradotta da Rosa Calzecchi Onesti viene “arricchita da segni di sottolineature, da commenti, fino a diventare un’opera nell’opera. Spazzini Villa è un artista milanese che vive a Roma, nel 2018 ha coinvolto 361 detenuti delle carceri italiane e ognuno di loro ha chiesto di sottolineare una frase per ogni pagina dell’Odissea” legge le parole che Spazzini Villa usò per spiegare il suo esperimento “Per me è uno specchio prismatico che si rifrange in tante odissee minori, in altrettanti ritorni. È il poema della conoscenza conseguita attraverso il superamento degli ostacoli. È una condizione che viene imposta ad Odisseo, lui la soffre, deve costruire la sua pace, deve costruirsi la via del ritorno e impiega dieci anni per percorrere questa strada. È il libro del mare, l’archetipo di ogni futuro romanzo di avventura. Ed è anche il poema degli umili: il leale porcaro Eumeo, la fedele nutrice Euriplea, il bovaro Filezio. Mi sono chiesto come sia visto Odisseo da una persona privata della libertà, che vive lontano da casa e dalla famiglia. Al contrario di Achille, che è un personaggio unitario, di marmo e di luce, Odisseo è tanti, è eroe, mendicante, viaggiatore, marito, con-dottiero, padre, amante. E una mente variopinta, sinuosa, che ben si adatta alla caduta delle strutture sociali di oggi. È il poema degli archetipi, il testo che contiene i moti del nostro animo, quelli che pensiamo di essere gli unici a vivere. È come se qualcosa dentro di me si sciogliesse quando leggo di un eroe che li affronta con coraggio e pazienza. Distribuivo ad ogni partecipante una sola pagina del testo omerico e su quella lui doveva lavorare. L'Odissea non è presa in considerazione per la sua struttura narrativa ma come insieme di immagini, segni, emozioni contenuti all'interno di una singola pagina, che diventa così un insieme di parole da cui estrarre quelle che più ci toccano, cercando di comporre, una frase di senso compiuto. È un gesto di verità, non estetico. Non c'è nulla di automatico ed inconscio - è un lavoro lontano dall’approccio al testo dadaista. Quello di sottolineare è un gesto lento in cui chi legge si rispecchia nelle parole del testo, le cerchia, le sottolinea, le cancella, le ritrova andando lentamente a comporre un ritratto di sé, di ciò che quella pagina riflette e rispecchia di sé.
Al progetto hanno partecipato anche alcuni studenti, ed è interessante capire quali siano le parole scelte dall’uno e dall’altro gruppo. Intanto le più sottolineate sono “cuore” e “mare”, che diventano due grandi spazi di riflessione, due specchi in cui leggere il mondo emotivo. «L’acqua/di mare/è casa» ha sottolineato qualcuno. «Il cuore/lontano da te/gridava/forte» sottolinea qualcun altro. I detenuti si identificano più con Odisseo, distante da casa e dagli affetti. Nelle frasi che hanno sottolineato si rivolgono alle mogli e ai figli lontani, alla casa abbandonata. «Era un massacro/il/ricordo/dell'amore/lontano», «Mi hai donato/ figli bellissimi/e io/ così misero». Gli studenti invece parlano più ai padri e alle madri: «Scusa/madre/per/ogni giorno», «Da tempo/mi impedisce il cammino/è mio padre» per citarne alcune”.
È un rito collettivo restituito, quello di Spazzini Villa: “L’Odissea nasce all’interno di una tradizione orale in cui aedi e rapsodi cantavano al popolo le gesta di eroi e di dei. Chi ascoltava ritrovava nelle loro parole gli archetipi dei propri moti d'animo - nostalgia, paura, ira, amore - e qualcosa andava sciogliendosi nella comprensione di non essere l'unico e il primo a vivere quei tormenti. È un testo collettivo in cui milioni di uomini, in migliaia di anni, hanno trovato e riconosciuto quel materiale altrimenti denso e informe che sono i moti del nostro animo, emozioni che con l’ascolto reiterato e ripetuto trova luogo e pace, sollievo e comprensione”.
E quanto ne abbiamo bisogno? “Nell'ultimo secolo abbiamo visto sgretolarsi i momenti di condivisione profonda all'interno delle società in cui viviamo, e tra questi anche quelli dell'arte. Nel suo piccolo questo progetto ne è lo specchio”.
L’esperimento si chiude con una detenuta del carcere di Bollate che durante un incontro si alza e dice “questa pagina mi ha spiegato la vita, cioè la mia vita”. Ecco tutto questo ci dovrebbe spiegare molto, molto sui lettori e su come oggi noi consideriamo quel noi che comprende gli scrittori e le scrittrici.
Accenna alle polemiche dei giorni scorsi su quanto faticose siano le presentazioni letterarie per alcune scrittrici e scrittori e con un sorriso dice “noi siamo seduti sul ramo di un albero, parlandone male, seghiamo quel ramo e andiamo giù” a quella polemica ci ritornerà in seguito.
Torna a parlare dell’importanza della lettura, facendo un altro salto indietro nel tempo. “Quasi vent’anni fa un grande giornalista culturale Paolo Mauri che sapeva riflettere bene sul mondo editoriale cita in un romanzo Una manciata di polvere di Evelyn Waugh ispirato ad un verso di una poesia di T.S. Eliot La terra desolata, un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere, sempre che sia ancora disponibile. C’è un uomo Tom Last che decide di effettuare un viaggio in Brasile per dimenticare i suoi guai sentimentali, durante la spedizione nella giungla si ammala il suo compagno di spedizione, il dottor Messinger muore e Tony nel delirio della febbre viene salvato da un contadino, Todd che vive in un villaggio isolato ed è analfabeta ma ama Dickens e costringe Tony con un fucile alla mano, a leggergli Dickens. Tom si salva con la lettura come Sherazade. Paolo Mauri cita questo libro per spiegare che chi legge ha sempre un fucile puntato contro, se smette qualcosa svanisce per sempre, non muore solo il lettore, muore tutto un mondo. Impossibile? è già accaduto un’infinità di volte. Ecco, c’è qualcosa che nei nostri tempi che mette a rischio non soltanto i libri, ma tutto il mondo che gira intorno ai libri, chi li scrive, chi li pubblica, chi li fa circolare. Il fucile è puntato da parecchi anni e lo hanno puntato almeno alcuni dei protagonisti della storia” tornando così all’importanza del discorso collettivo.
Si ferma sui numeri, perché la crisi delle vendite è innegabile e cita i dati dello studio presentato a Più libri più liberi dall’associazione italiane editori. Tra gennaio e ottobre 2024 si sono vendute un milione e 700mila copie in meno rispetto allo stesso periodo del 2023: a perdere sono soprattutto gli editori più piccoli, ovvero -4,9% per chi vende annualmente fino a un milione di euro, -3,6% per chi ha vendite comprese tra uno e cinque milioni di euro. I grandi marchi, più o meno, tirano avanti. Dunque? Ancora un passo indietro. A giugno 2023 uno studio Nomisma raggelava gli scrittori con queste cifre: il 30 per cento dei libri pubblicati non vende una copia, o al massimo ne vende una. Fra i libri usciti nell’anno immediatamente precedente nemmeno 35mila hanno raggiunto le 10 copie vendute. Ancora indietro: ad aprile 2024, l’editore Riccardo Cavallero traumatizzò la platea letteraria di Facebook pubblicando il venduto dei romanzi nella dozzina finalista dello Strega (ovviamente prima che entrassero nella dozzina medesima): spaziava dalle 400 copie alle oltre 50.000 di Donatella Di Pietrantonio che ne sarebbe stata vincitrice.
“Perché non si vende? Perché i lettori sono cattivi? sono pigri? no non si vende perché si pubblicano troppi libri. Nel 2025 probabilmente a fine anno sfioreremo i 100.000 titoli e nessun lettore al mondo riuscirebbe a stare dietro una produzione simile dove è evidente che la gran parte di quelli pubblicati in un mese è sacrificabile. Perché non ci si può liberare del misterioso meccanismo delle rese che rende il ciclo vitale di un libro fra i 15 e i 30 giorni, a meno naturalmente di un successo inaspettato o di un premio letterario prestigioso. Come denunciarono nel 2011 i piccoli editori del Festival di Belgioioso. Un libro vive un tempo enormemente, ma proprio enormemente minore di quanto c’è voluto per pensarli, scriverli, scegliere una copertina, stamparli, distribuirli e promuoverli. Quindici, venti, massimo 30 giorni”. Il presidente dell’Associazione Librai Italiani, che all’epoca era Paolo Pisanti, disse con chiarezza che la causa era la troppa offerta, e poco curata: “sessantamila novità l’anno (nel 2011) sono una cifra incredibile rispetto a qualsiasi categoria merceologica, e senza soluzione di continuità. Un pasticcere sa che ci sono i momenti più impegnativi, come il panettone a Natale e la colomba a Pasqua. Noi non abbiamo pause. Non possiamo far altro che sostituire le quasi-novità con altre novità. Perché per fare spazio ai nuovi arrivi abbiamo bisogno di liberare i magazzini, e prima ancora di passare dalla vetrina al banco e dal banco allo scaffale: ci sono tempi tecnici, e tempi finanziari. I pagamenti all’editore avvengono mediamente a novanta giorni. Se voglio fare un’operazione economicamente valida, devo vendere i libri prima di pagarli, ma in tempi così brevi è difficilissimo. Dunque, diventa antieconomico tenere un libro che stenta a decollare più di venti-trenta giorni”.
I numeri non sono opinabili, almeno in termini assoluti e così Lipperini si sofferma ancora “A costo di essere didascalici, funziona così: un editore incassa il 50% sul prezzo di copertina una volta ricevute le prenotazioni di un libro (il restante si divide fra libreria e la vera vincitrice di tutto, la distribuzione), ma quando le copie non vendute vengono rese al distributore, quest’ultimo chiede all’editore il rimborso, e dunque per ripianare il debito l’editore dovrà stampare un nuovo libro per incassare di nuovo. Il risultato è che di quei milioni di copie stampate nel 2024 ne torna indietro la metà. Che verrà con ogni probabilità mandate al macero, perché chi ha magazzini abbastanza grandi per conservarla? Se tutto questo vi ricorda la grande bolla finanziaria esplosa nel 2008 con le conseguenze che sappiamo, avete ragione. Se vi interrogate sul perché gli editori continuano a reiterare il meccanismo, ho paura che la risposta sia: perché non possono più fare diversamente”.
Il discorso è ampio e sfaccettato, parla di tutti, anche degli scrittori “c’è un peso che grava un po’ su tutti, su chi esordisce e su chi non è esordiente, la corsa al libro di successo, tutti desiderano il bestseller. Viviamo in tempi che ci vogliono performanti vincenti, creatori di valore, direbbe Mark Fisher direbbe che non aspirano ad altro che creare un valore ed essere riconosciuti in base a quel valore. Sapete cosa succede? Succede che anche le più belle scritture si possono rovinare quando si cerca disperatamente il bestseller, si tralascia il tempo della scrittura”.
Ancora numeri: nel 2023 la spesa media mensile per i consumi delle famiglie è stata di 2.738 euro, dove devono rientrare le spese per la casa, per il cibo, per i vestiti, per le scarpe, per la scuola, per i medicinali, per il riscaldamento e tutto quello che volete. Ai libri non scolastici si riserva il 3,71%. E proprio in questi numeri si nasconde una crepa e quasi nessuno fa lo sforzo di guardarci dentro, lei si “In tutti i discorsi sulla mancata lettura e sulla crisi dell’editoria manca sempre il discorso sugli stipendi degli italiani. Che sono fermi. Parliamo subito di soldi. Ogni volta che si fa questo discorso salta fuori qualcuno che col ditino alzato dice: «E allora lo spritz? E allora l’iPhone? E allora le macchinone? ». Non funziona esattamente così. Mi ha scritto un amico, Simone Romano, che mi ha raccontato questa storia. “Siamo”, dice, “un gruppo di amici. Disoccupati o part time, stipendi sotto i mille euro mensili. Ma siamo lettori forti, e spesso non vogliamo aspettare che le biblioteche acquisiscano quel titolo che stavamo aspettando, e ogni mese ce ne sono diversi. Ma i libri costano fra i quindici e i venti euro, e la spesa diventa impossibile. Dunque, li compriamo insieme: ognuno versa una piccola quota, in modo che, dividendo il costo totale fra cinque persone, l’acquisto diventa accessibile. Come li leggiamo? Tirando a sorte: estraiamo i biglietti con i nostri nomi da un cestino, e il primo estratto inizia la lettura, che poi passa agli altri. Alla fine, qualcuno tiene fisicamente in custodia il libro: c’è un ex libris con i nostri nomi, su Google Drive c’è un file con i titoli acquistati e il nome di chi lo tiene in consegna. Ognuno ha dedicato una sezione della libreria al booksharing, dove si tengono i libri in comune, che possono essere richiesti per rilettura in qualsiasi momento. È un paradosso. Anche in questo caso legato alle tante uscite e soprattutto alla scarsità di soldi. Mi rendo conto che il mercato editoriale non viene aiutato da questo sistema, perché un solo testo viene letto da cinque persone. Ma come si fa? I libri aumentano, in numero e costo, e gli stipendi non crescono, e il lavoro nemmeno. Quindi il problema non è l’editoria, o non solo: è il lavoro. Quindi il problema tra le altre cose è il lavoro. Pensare che la lettura sia slegata dalla società e l’errore più grave che possiamo commettere: la lettura, la letteratura, la scrittura sono intimamente legate a quello che le circonda”.
Finalmente qualcuno l’ha detto. Il dito puntato frettolosamente sui lettori, pigri, svogliati e ignoranti questa volta svanisce, sostituito da un discorso che come il prisma di Odisseo sa guardare ogni singola faccia e con ognuna di esse compone la figura finale.
Lipperini lascia per la seconda parte della sua lectio magistralis la poesia e l’incanto della lettura che non vanno persi mai “Arrivo ai lettori, Brodskij nel 1988 inaugurava la prima edizione del salone del libro di Torino, nel suo discorso invitava i lettori e costruirsi una bussola interiore per orientarsi nel mare della letteratura. Diceva anche che era importantissimo che lo facessero perché la letteratura era l’unica forma di assicurazione morale di cui una società può disporre. Io ìsono una lettrice professionista, leggo articoli e sento parlare di letteratura quasi esclusivamente in termini di mercato e di competizione se si entra nella finale di un premio o meno quanto si vende quanto sui giornali si parla dei propri libri se il nuovo titolo è stato citato o meno online o non online sull’uscita del mese. Invece quanto sarebbe bello che qualcuno picchiasse le dita sulla tastiera per ripetere parole simili a Brodskij, perché nella maggior parte dei casi, io sento di scrittori e scrittrici che preferiscono lamentarsi della propria sorte e spesso anche delle lettrici e dei lettori che coprano i libri brutti”.
Cita anche Shirley Jackson e una sua lezione sulla scrittura contenuta in un libro che si chiama Paranoia dove “parlava ironicamente del lettore come nemico e diceva che il lettore è una specie di partner, l’unico vero implacabile nemico dello scrittore, ha tutto dalla sua parte e non deve far altro che chiudere gli occhi e l’opera perderà ogni significato. Inoltre rispetto a uno scrittore principiante, il lettore ha il vantaggio di non esserlo mai, prima di cominciare a leggere un racconto magari ha già letto tutto. Il lettore è un nemico da sconfiggere con ogni trucco sleale che lo scrittore possa escogitare per conquistare «l’inqualificabile buzzurro sull’amaca e di tenere sveglia la sua curiosità senza farlo addormentare».
Cita anche Enrique Vila-Matas quando disse che il lettore attivo non si limita a consumare il libro ma lo completa.
“Ecco l’altro punto, io ho la sensazione che le scrittrici e gli scrittori parlino meno di lettura. Penso a un bellissimo intervento di Susan Sontag sull’arte di rileggere quando confessava che gli scrittori leggessero meno e diceva che l’amore per la lettura è quello che ti fa sognare di diventare scrittore e dopo che lo sei diventato leggere i libri scritti da altri e rileggere i tuoi libri preferiti, rappresenta un irresistibile distrazione dallo scrivere. Distrazione, consolazione, tormento e ispirazione. Naturalmente non tutti gli scrittori lo ammetteranno”.
Anche questo oggi in parte si è perso, “Molti scrittori ormai non più giovani sostengono di leggere poco, di considerare letture e scritture in qualche modo incompatibili e forse per alcuni è davvero così. Forse dipende dal timore di essere influenzati o dalla mancanza di tempo, le ore che passi a leggere, ovviamente non puoi scrivere”.
Torna al discorso collettivo e in quanto tale politico della lettura, parla delle “forme di resistenza che secondo me devono essere plurali. Forse insieme ai grandi e ai grandissimi festival servono presidi, servono i nidi di vespe per parafrasare la magnifica resistenza di un quartiere di Roma il Quadraro durante la seconda guerra mondiale. Se voi ci andate c’è un bellissimo murale con una grande vespa perché nidi di vespa era il termine con cui i tedeschi definivano i partigiani del Quadraro e l’intero quartiere, uno di quelli che oggi direbbero che è degradato e invece la resistenza anche nella lettura si fa lì. Vi cito una piccola cosa che però mi sembra importante. A fine febbraio ho visitato la prima edizione di Oblivion è la fiera del libro del fumetto e dell’irrazionale quindi letteratura fantastica che si è svolta a Roma. Si deve un gruppo di amici, piccoli editori, è costata 14.500 euro, 45 case editrici presenti, ha raccolto quasi 5000 visitatori, nel weekend ingresso gratuito, punti di ristoro e nasce come progetto politico per dimostrare che è possibile realizzare un prodotto culturale di qualità ed economicamente sostenibile unendosi, perché unirsi è sempre meglio di competere”.
Torna a Shirley Jackson e ai lettori e alle lettrici che a dispetto dei pochi soldi ed al poco tempo vogliono essere avvinti.
“Lo dimostra il proliferare in ogni città piccola e grande dei gruppi di lettura che sono la cosa più bella che noi abbiamo in questo momento, perché sono spontanei, perché sono entusiasti e perché scelgono democraticamente il libro da leggere, perché si fanno portatori di lettura come moltitudine perché i loro invitare lo scrittore non è un compiacimento, non è chiedere di scattarsi un selfie con lo scrittore, è conoscerlo e discutere anche contestare parti del suo libro. I lettori si devono andare a trovare è la cosa più importante che chi scrive possa fare in questo momento. Eppure da ultimo, come dicevo si legge un po’ dappertutto la protesta di scrittori e scrittrici contro le presentazione dei libri” al proposito cita il caso editoriale de Gli uomini pesce di Wu Ming 1 e le 150 presentazioni fatte in un anno e le 27mila copie vendute.
Legge la risposta di Wu Ming “Presentare e ciò che fa vivere un libro e nei casi migliori lo trasformano in un coltellino svizzero a disposizione di chi vive i terriori. In questi mesi Gli uomini pesce – certo, per i temi che tocca e per come lo fa, ma anche perché lo sto portando in giro a più non posso – è diventato un dispositivo per catalizzare energie e far convergere soggetti diversi. Alle presentazioni di questo libro sono nate collaborazioni, alleanze e amicizie. E questo non è esclusivo dei libri di Wu Ming: mutatis mutandis, può accadere con altri libri, è accaduto, accade.Noi abbiamo questo “pallino” del corpo, dei corpi. Senza il corpo non vai da nessuna parte, letteralmente. Tornare a fare cose insieme coi corpi è l’unico vero modo di arginare l’epidemia di solitudini, il terribile sfilacciarsi delle relazioni. Sempre più persone, prive di amicizie, passano le ore parlando con un chatbot. In questo quadro di desolazione, chi muove le terga per venire alla presentazione di un libro sta già facendo qualcosa di importante. Solamente gli stolti possono guardare a questo con sufficienza, e solamente – mi si permetta – gli stronzi possono parlarne con disprezzo. Incontrare lettrici e lettori è già politico, mi spingo a dire che è già lotta. La letteratura non è politica tanto per il suo contenuto, quanto per i legami che può stabilire. I colleghi e le colleghe che pensano di sostituire questo con una presenza – e una vanvera tuttologica – a getto continuo sui social si stanno consegnando all’irrilevanza. Irrilevanza non a livello mediatico: irrilevanza nella vita delle persone in carne e ossa”.
Un altro salto, Margaret Arwood e la sua partecipazione alla biblioteca del futuro e Norvegia, dove gli autori e le autrici regalano un inedito che verrà sepolto e portato alla luce dopo 100 anni.
Alla domanda “cosa si prova ad aver scritto qualcosa che nessuno leggerà prima che io sia morta?” rispose “la stessa cosa succede adesso tranne che per lo scarto temporale maggiore, non si può mai sapere chi potrà leggere il tuo libro o dove o quando non si può mai sapere chi sarà il caro lettore e la cara lettrice, ma scrivere senza pensare al caro elettore e alla cara lettrice è un gesto inutile”.
Il gran finale, Lipperini ha completato la tela sul suo immenso colorato telaio “Può soddisfare se stessi ma la scrittura come l’Odissea è fatta per generare moltitudini per farci riconoscere nelle emozioni di un testo e per condividerle in questo senso la scrittura e sempre, sempre, politica anche se lo si nega. Il lettore ci sarà è un fatto anche se non si può provare. Meglio è una speranza, forse però se non siamo in grado di pensare in prospettiva, neanche in questo caso, ecco che sediamo al ramo dove siamo seduti. Bisogna resistere, grazie all’elettricità, ai lettori grazie alle parole condivise, creando i nostri nidi di vespe”.
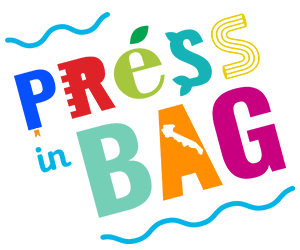
www.pressinbag.it è una testata giornalistica iscritta al n. 10/2021 del Registro della Stampa del Tribunale di Bari del 10/05/2021.
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitare a contattarci scrivendo ai seguenti indirizzi